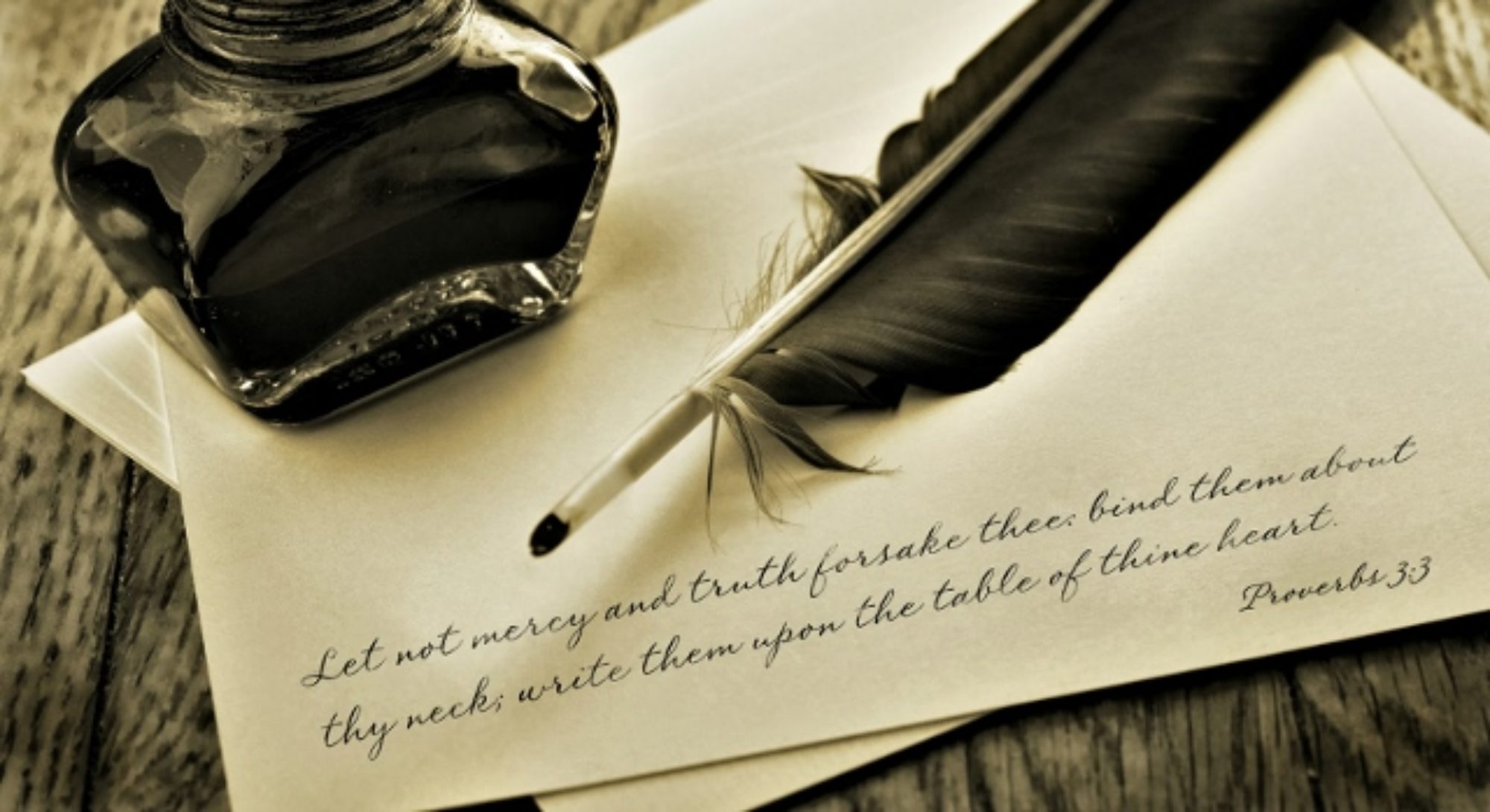L’auto è una piccola fortezza.
Un mezzo con la forza di portarti lontano dai pericoli, di farti scappare dai problemi o di portarti sui problemi per farteli affrontare con più determinazione.
Un luogo sicuro in cui rintanarsi quando se ne sente l’esigenza.
Sei consapevole non appena lo sportello è chiuso, di essere solo ma in buona compagnia (non sempre) di se stessi, dei propri pensieri.
È un luogo magico l’abitacolo della propria vettura.
Uno dei pochi posti in cui si potrebbe quasi dire: “sono a casa”.
Riconosci ogni oggetto al suo interno.
Ad un occhio disattento, quegli oggetti possono sembrare abbandonati lì per caso, ma in realtà ci sono per un motivo preciso.
Un motivo conosciuto solo da te.
Tu solo sai perché hai deciso di promuoverli come prodotti indispensabili da avere a vista d’occhio, da poter afferrare con un solo gesto della mano.
La notte o mentre piove sono i due momenti ideali per starsene su quel sedile, almeno per me.
Momenti entrambi capaci di oscurare la luce esterna annebbiarla, per lasciare la mente libera di frugare nel pozzo delle proprie sensazioni.
Tutto sembra disegnato, progettato per creare l’atmosfera giusta per invertire il flusso delle emozioni.
Invece di riceverle dall’esterno (a volte subirle) lasciare che defluiscano dall’interno, quasi per liberarsene.
Così questa mattina.
Piccole gocce di pioggia rimbalzano senza sosta sul vetro.
Disegnano minuscoli poligoni informi, regalano la sensazione di offuscamento, deformano i contorni del mondo esterno, tratteggiano piegando senza rispetto i fasci luminosi delle luci artificiali.
La strada al lato scorre come tanti piccoli fermi immagini, brevi momenti della durata di un attimo, un lungometraggio senza audio, ma chiaro da interpretare – tutti occupati a proteggersi, coprirsi, non mostrarsi. –
Così fa il papà con in braccio il proprio figlioletto per ripararlo dal freddo.
Così fa la coppia di vecchietti mano nella mano attenti ad aiutarsi a vicenda nell’attraversare la strada con quel tempaccio arrabbiato.
Nel frattempo, all’interno della macchina Renato Zero canta: “Non cancellate il mio mondo”.
Il tempo scorre lento o l’impressione dello scorrere è svogliato, ovattato.
Le premesse per un momento di pura malinconia sembrano esserci tutte, sembra il set perfetto per sfogare momenti nostalgici.
La piccola voce interiore dice la sua:
“dai sfogati, piangi, disperati, richiama alla mente i ricordi più belli e usali come cilicio contro di te, vedrai ti sentirai meglio.”
A volte è meglio non ascoltarla quella voce, ha lo scopo unico di accelerare la zattera in balia del vortice diretto verso il buco nero al centro della tristezza.
Ma fortunatamente non è sempre così.
Perché quella fortezza in cui ti trovi, la minuscola casa mobile trasformata a tua somiglianza ha lo scopo di ricordarti di essere al sicuro, protetto.
Trovarsi al riparo dalla pioggia, dargli le sembianze di piccoli dipinti mobili, avere l’accompagnamento di melodie sempre diverse è un modo per convincersi che:
“qualunque cosa accada fuori, lì dentro si è al sicuro, si è protetti, si è al caldo, ci si trova nel posto disegnato da noi stessi per essere più vicini al nostro essere sereni”.
Perché tutti hanno momenti in cui inaspettatamente ci si trova a veder comparire all’improvviso, senza premesse, la trama di un film horror, ma in quei casi bisognerebbe avere la forza di entrare in macchina, accendere la radio e farsi un giro per la città , non per scappare, ma per sentirsi al sicuro.
Per sentirsi a casa.